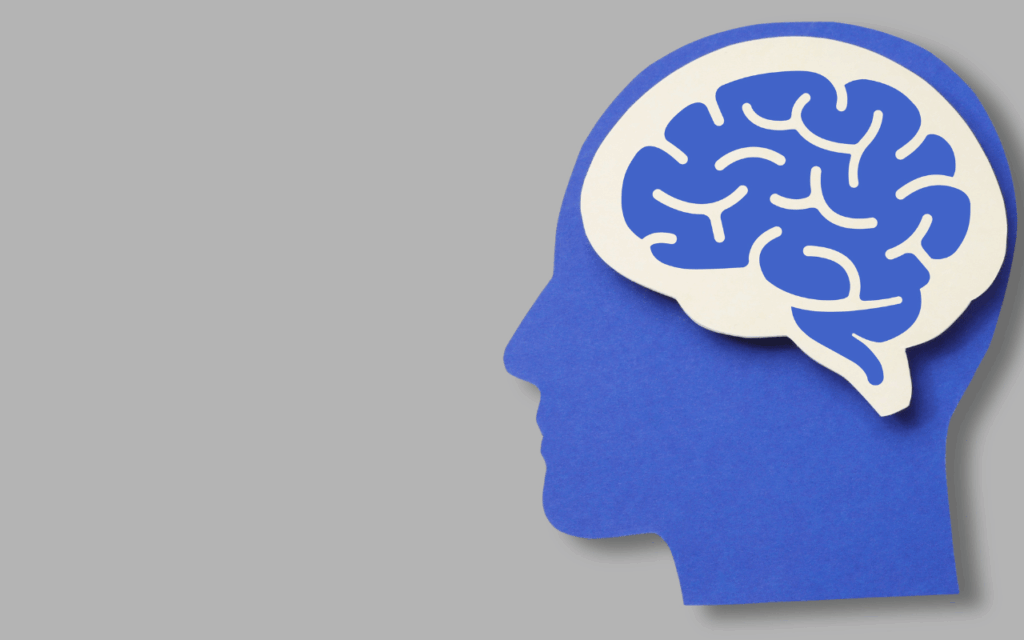L’Unità Operativa di Neuroriabilitazione ad Alta Intensità (Codice 75) accoglie pazienti con gravi cerebrolesioni acquisite (GCA) che presentano compromissioni motorie, cognitive e comportamentali tali da determinare una grave disabilità e la necessità di un trattamento riabilitativo intensivo, continuativo e multidisciplinare.
L’obiettivo generale è il recupero delle funzioni compromesse, la prevenzione delle complicanze secondarie e la promozione della massima autonomia residua del paziente, in un contesto clinico assistenziale ad alta complessità.¹
Gravi cerebrolesioni acquisite (GCA):
Le GCA includono patologie che, a seguito di un danno cerebrale, possono portare a gravi disabilità fisiche e cognitive, alterazioni della coscienza, disturbi del linguaggio e del comportamento. La riabilitazione cod. 75 è fondamentale per massimizzare il potenziale di recupero in questi pazienti complessi
Le gravi cerebrolesioni acquisite (GCA) sono danni cerebrali non congeniti che compromettono in modo significativo il funzionamento del cervello, spesso con conseguenze motorie, cognitive, comportamentali e relazionali di lunga durata. Per “cerebrolesione acquisita” si intende una lesione cerebrale che:
- Non è presente alla nascita (non congenita),
- È acquisita dopo un periodo di sviluppo neurologico fisiologico
- può avere un’origine traumatica o non traumatica,
- Provoca una compromissione grave e persistente delle funzioni neurologiche.
Sono tra le principali cause di disabilità grave nell’età adulta e giovanile.
INCIDENZA E PREVALENZA NEL MONDO E IN ITALIA
Dati globali
- Lo studio Global, regional, and national burdens of traumatic brain injury (GBD 2021) stima che nel 2021 ci siano stati circa 20,84 milioni di nuovi casi di TBI (traumatic brain injury) nel mondo che sono moderate/severe.
- L’incidenza globale age-standardizzata per tutti i TBI è di ~ 259 casi per 100.000 persone (95% UI: 226296) nel 2021.
- La prevalenza globale age-standardizzata è stimata in ~ 448 casi per 100.000 persone nel 2021 (cioè persone che convivono con TBI)
- Per la sola componente “moderata/severa”, l’incidenza e danni associati sono grandi fonti di disabilità e mortalità, specialmente nei paesi a basso / medio reddito.
Dati per l’Italia
I dati italiani sono più scarsi e frammentari, e spesso usano la categoria “Gravi cerebrolesioni acquisite (GCA)” con criteri specifici regionali.
- Si stima che ogni anno in Italia ci siano 1015 casi nuovi di GCA ogni 100.000 abitanti.
- Per la prevalenza: circa 300800 casi ogni 100.000 abitanti convivono con GCA, con un numero totale stimato superiore a 150.000 persone.
- In Toscana: circa 460760 nuovi casi/anno di GCA. Nella stessa regione, tra i 90150 casi/anno di stati vegetativi; prevalenza intorno ai 110210 casi (di stato vegetativo) nella popolazione regionale.
- In EmiliaRomagna, un dato riferisce che “circa 1.300 persone/anno” con GCA vi siano nella regione come nuova incidenza (ma è un numero regionale).
CAUSE PRINCIPALI
1. Traumi cranici
- Incidenti stradali
- Cadute
- Infortuni sportivi
- Aggressioni
Spesso coinvolgono lesioni cerebrali traumatiche (TBI – Traumatic Brain Injury), che possono variare da commozioni cerebrali a lesioni estese.
2. Ictus cerebrale
- Ischemico (occlusione di un vaso sanguigno cerebrale)
- Emorragico (rottura di un vaso con emorragia)
Provoca un’interruzione dell’afflusso di sangue e ossigeno al cervello, causando danni ai tessuti.
3. Anossia o ipossia cerebrale
- Arresto cardiaco
- Asfissia
- Annegamento
- Intossicazioni (es. monossido di carbonio)
Mancanza totale (anossia) o parziale (ipossia) di ossigeno al cervello, con danni diffusi.
4. Infezioni cerebrali
- Encefalite (virale o batterica)
- Meningite
Possono causare infiammazioni del cervello o delle sue membrane, con danni strutturali.
5. Tumori cerebrali
- Tumori primari o metastasi
- Effetti della massa tumorale o della chirurgia/radioterapia
Possono provocare lesioni dirette o secondarie al tessuto cerebrale.
6. Interventi neurochirurgici complicati
- Complicanze post-operatorie
- Emorragie intra-operatorie
7. Malattie neurologiche rare o autoimmuni acute
- Leucoencefalopatie rapidamente progressive
- Sindrome di Guillain-Barré con interessamento encefalico
- Encefalopatie autoimmuni
Le CONSEGUENZE di una GCA possono essere molto variabili, a seconda della localizzazione, estensione e gravità del danno. Di seguito le principali possibili conseguenze:
Conseguenze neurologiche e cognitive
- Disturbi della memoria (a breve o lungo termine)
- Difficoltà di attenzione e concentrazione
- Compromissione delle funzioni esecutive (pianificazione, problem-solving, autocontrollo)
- Afasia (disturbi del linguaggio, espressivo o ricettivo)
- Apraxia (difficoltà nell’eseguire movimenti coordinati)
- Agnosia (difficoltà nel riconoscere oggetti, persone, suoni)
- Disturbi della percezione e orientamento spaziale
Conseguenze motorie e fisiche
- Emiparesi o emiplegia (debolezza o paralisi di un lato del corpo)
- Spasticità o rigidità muscolare
- Atassia (perdita di coordinazione)
- Disturbi dell’equilibrio e della deambulazione
- Disturbi visivi e uditivi
- Epilessia post-traumatica
- Disturbi della deglutizione (disfagia)
Conseguenze comunicative
- Difficoltà a parlare o comprendere il linguaggio
- Disartria (difficoltà nella produzione articolata dei suoni)
- Problemi nella comunicazione pragmatica (es. capire metafore, turni di parola)
Conseguenze psichiche e comportamentali
- Alterazioni della personalità
- Impulsività, aggressività o apatia
- Labilità emotiva (cambiamenti emotivi rapidi e incontrollati)
- Depressione, ansia o disturbi dell’umore
- Disturbi del sonno
- Disinibizione sociale
Conseguenze sociali e relazionali
- Difficoltà nel reinserimento lavorativo o scolastico
- Isolamento sociale
- Cambiamenti nella dinamica familiare
- Dipendenza da caregiver
Esiti a lungo termine
- Disabilità permanente (da lieve a grave)
- Necessità di assistenza continua
- Riduzione della qualità della vita
- Possibile stato vegetativo o stato di minima coscienza, nei casi più gravi
PROGNOSI: FATTORI CHE LA INFLUENZANO
Fattori positivi (migliore prognosi)
- Età giovane del paziente
- Assenza di patologie pregresse
- Danno cerebrale limitato (in estensione e localizzazione)
- Tempestività e qualità degli interventi medici e riabilitativi
- Supporto familiare e sociale efficace
- Buona motivazione e collaborazione del paziente
Fattori negativi (prognosi più sfavorevole)
- Estensione grave e diffusa della lesione cerebrale
- Età avanzata
- Coma prolungato (>2-4 settimane)
- Complicazioni mediche secondarie (infezioni, crisi epilettiche, ecc.)
- Assenza o ritardo nella riabilitazione
- Condizioni socio-ambientali svantaggiate
La PROGNOSI può variare dal recupero completo a esiti permanenti gravi, fino allo stato vegetativo persistente o alla morte. Di seguito, alcune evoluzioni tipiche:
Recupero parziale o completo
- Possibile nei casi meno gravi o in pazienti giovani e trattati precocemente
- Richiede anni di riabilitazione intensiva
- Il recupero cognitivo può essere più lento di quello fisico
Esiti permanenti ma con autonomia parziale
- Deficit cognitivi o motori persistenti, ma con mantenimento di una certa autonomia
- Può essere possibile un reinserimento sociale o lavorativo con supporti
Esiti gravi con disabilità permanente
- Paziente non autonomo nelle attività della vita quotidiana
- Necessità di assistenza continua
- Difficile reinserimento nella vita sociale
Stato vegetativo o di minima coscienza
- Possibile esito nei casi di coma prolungato o danni cerebrali diffusi
La prognosi delle GCA è altamente individuale. Anche in caso di grave compromissione iniziale, non si può mai escludere del tutto un recupero, almeno parziale. Tuttavia, è importante avere aspettative realistiche, basate sull’evoluzione clinica, e garantire al paziente un percorso di cura e sostegno continuativo.
Il Codice 75 in ambito sanitario, quando associato a neuroriabilitazione, può fare riferimento a una specifica prestazione o intervento riabilitativo destinato a pazienti che necessitano di trattamento per il recupero da danni neurologici. Questi trattamenti sono finalizzati a migliorare la qualità della vita, recuperare funzioni compromesse o mitigare gli effetti di disabilità derivanti da patologie neurologiche.
Finalità principali della neuroriabilitazione
Recupero delle funzioni motorie e cognitive:
La neuroriabilitazione aiuta i pazienti a recuperare abilità motorie (come la coordinazione o la mobilità) e cognitive (come memoria e attenzione) dopo danni cerebrali.
- Miglioramento della qualità della vita:
Fornendo un supporto per il miglioramento delle capacità funzionali, si punta a rendere i pazienti più autonomi nelle attività quotidiane. - Previene complicazioni secondarie:
Ridurre il rischio di atrofia muscolare, piaghe da decubito, o altre problematiche che possono derivare dalla disabilità. - Trattamento mirato e personalizzato:
La riabilitazione neurologica è altamente individualizzata e basata sulle specifiche esigenze del paziente (ad esempio, trattamenti per il recupero del linguaggio, della memoria, o delle abilità motorie).
L’accesso al Codice 75 – Neuroriabilitazione avviene generalmente all’interno del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ed è regolato da criteri clinici, burocratici e amministrativi specifici. Il “Codice 75” si riferisce, in molte regioni italiane, alla riabilitazione neurologica intensiva o estensiva erogata in regime residenziale, semiresidenziale o ambulatoriale, ed è codificato nel sistema dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza).
Modalità di accesso
1. Valutazione specialistica e diagnosi
- Serve una diagnosi neurologica da parte di un medico specialista (neurologo, fisiatra, neurochirurgo).
- Il paziente deve presentare una condizione neurologica che giustifichi un percorso riabilitativo intensivo o estensivo (ictus, trauma cranico, lesione midollare, sclerosi multipla, Parkinson, ecc.).
2. Presa in carico da parte di un centro riabilitativo
- Il medico specialista o l’équipe ospedaliera effettua una richiesta di accesso alla neuroriabilitazione (modulo specifico o lettera di dimissione).
- La richiesta viene inviata a un centro di neuroriabilitazione accreditato presso il SSN.
3. Valutazione multidisciplinare e piano riabilitativo individuale (PRI)
- Il centro effettua una valutazione clinica multidisciplinare (fisiatra, terapisti, logopedista, psicologo, ecc.).
- Se i criteri sono rispettati, si formula un Piano Riabilitativo Individuale (PRI) con obiettivi, tempi e modalità del trattamento.
4. Approvazione e autorizzazione ASL
- In alcuni casi (soprattutto in regime residenziale o semiresidenziale), serve l’autorizzazione dell’ASL di competenza, che valuta:
- Appropriatezza clinica
- Disponibilità dei posti letto
- Copertura economica
- La ASL rilascia un nulla osta/autorizzazione al ricovero in codice 75.
5. Accesso alla struttura e inizio del trattamento
- Una volta ottenuta l’autorizzazione, il paziente accede alla struttura (ambulatoriale, semiresidenziale o residenziale) per iniziare il percorso riabilitativo.
Il Progetto Riabilitativo Individuale rappresenta lo strumento operativo centrale del percorso.
È redatto entro le prime 72 ore dall’ingresso e definisce:
- diagnosi funzionale iniziale e obiettivi a breve, medio e lungo termine;
- programmi di intervento integrati per area motoria, cognitiva, logopedica, neuropsicologica e respiratoria;
- durata prevista del trattamento e criteri di verifica periodica;
- coinvolgimento attivo della famiglia e del caregiver.
Il PRI è condiviso dall’équipe multidisciplinare e aggiornato in relazione ai progressi del paziente. La durata e l’intensità del trattamento devono garantire almeno tre ore di attività riabilitativa giornaliera, distribuite tra le diverse aree di intervento. ²
Ambiti di intervento
Sono candidabili al trattamento in cod. 75 i pazienti che presentano:
- esiti di coma prolungato (GCS < 8 in fase acuta, GOS 2–3, LCF 1–4, DRS ≥ 17);
- tetraparesi/tetraplegia, gravi disturbi cognitivi e comportamentali post-lesionali;
- disautonomia, spasticità severa, disfagia, tracheostomia, dipendenza totale per le ADL;
- necessità di monitoraggio cardiorespiratorio o di nutrizione enterale/parenterale. ³
Le prestazioni riabilitative comprendono:
- riabilitazione motoria e funzionale (fisioterapia, idrochinesiterapia, prevenzione delle complicanze da immobilità);
- riabilitazione cognitiva e del linguaggio (logopedia, foniatria, neuropsicologia);
- riabilitazione respiratoria e disfagia (rieducazione alla deglutizione, gestione tracheostomia, monitoraggio ventilatorio);
- riabilitazione ortottica e visiva;
- supporto psicologico al paziente e alla famiglia;
- valutazione e prescrizione di ausili e piani di reinserimento socio-familiare. ⁴
Trattamenti e standard organizzativi
La struttura assicura:
- Attività riabilitativa multidisciplinare quotidiana, con programmi individualizzati;
- Disponibilità di diagnostica di supporto (TC, RM, EEG, EMG, potenziali evocati, endoscopie ORL, urodinamica);
- Procedure di emergenza interne e collegamento funzionale con reparti per acuti;
- Continuità assistenziale post-dimissione mediante raccordo con servizi territoriali e domiciliari. ⁵
Équipe multidisciplinare
L’équipe minima è così composta:
- Specialisti in fisiatria (numero specialisti) con esperienza in neuroriabilitazione;
- Specialisti in neurologia (numero specialisti)
- Infermieri professionali
- Operatori Socio-Sanitari
- Fisioterapisti, terapisti occupazionali, logopedisti, ortottisti, psicomotricisti;
- Psicologo/neuropsicologo (presenza continuativa o part-time);
- Assistente sociale;
- Coordinatore di area riabilitativa e direttore medico responsabile.⁶
È inoltre prevista la possibilità di consulenze specialistiche (neurochirurgia, pneumologia, urologia, otorinolaringoiatria, cardiologia, chirurgia plastica e generale) attraverso protocolli formali con le strutture ospedaliere di riferimento.
Riferimenti normativi e linee guida
- Ministero della Salute, Piano di indirizzo per la Riabilitazione, G.U. n. 50 del 1° marzo 2011.
- D.M. 2 aprile 2015, n. 70, “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”.
- Regione Campania, Requisiti minimi per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture di neuroriabilitazione ad alta intensità (Cod. 75), allegati al Piano di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera Regionale (DCA n. 8/2018 e s.m.i.).
- Istituto Superiore di Sanità, Linee guida su “Gravi cerebrolesioni acquisite e percorsi di neuroriabilitazione intensiva”, Rapporti ISTISAN, 2013.
- Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa (SIMFER), Linee guida per la riabilitazione del paziente con gravi cerebrolesioni acquisite, 2021.